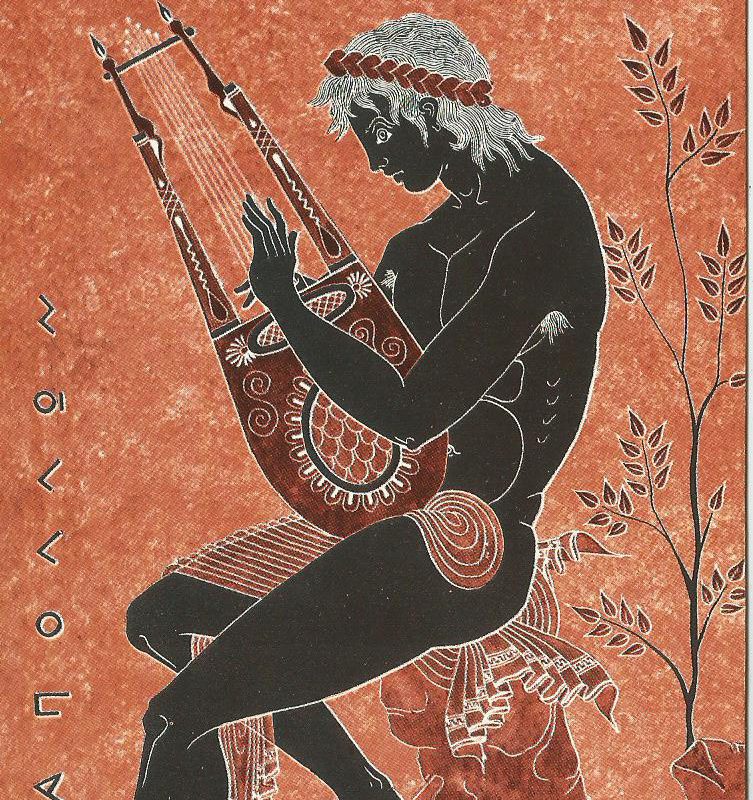Premiazione nell’abazia romanica di san Fedele a Poppi al 50° Premio Letterario Casentino, dove ho conseguito il premio speciale della Giuria per la saggistica per il mio libro “Ultreya e Suseya! Il Giubileo e i pellegrini, ieri e oggi “. Luogo che non poteva essere più suggestivo e appropriato per il mio libro. Non solo perché l’opera è incentrata sulla spiritualità religiosa e i cammini dei pellegrini erano costellati di pievi romaniche, ma anche per il motivo, come ho anche detto alla premiazione, che proprio in queste chiese, con le loro linee rette semplici ed essenziali che nell’abside sfociano in quelle curve, si ha la visione di un finito che sfocia nell’infinito e genera un’infinità rassicurante. Ecco quanto si legge in proposito nel mio libro:
Anche le cattedrali gotiche con tutta la loro luce e grandiosità, il loro slancio verso il cielo, mi attraggono. Manifestano uno dei tanti aspetti del Signore, danno il senso dell’immensità, del Dio dell’universo. Belle, ma anche un po’ sconcertanti. Perché tutte le creature hanno bisogno di un nido o di una tana, e limitati come siamo non possiamo trovare appiglio nell’infinito impersonale, in un infinito indefinito. Tanto più io, che soffro anche di vertigini, sento il bisogno di un contorno definito, di un punto di appoggio, dell’intimità della penombra. Di quel raccoglimento che tante volte ho cercato e trovato nelle chiesette romaniche di campagna con le loro forme rigorose e spoglie, con le loro geometrie semplici ed essenziali.
Uno stile, quello romanico, che non rimanda a uno spazio chiuso o alla tomba (io soffro pure di claustrofobia), ma appare come grembo materno che si apre all’infinito, a pace e luminosa vita, vicinanza alla terra e trascendenza in un altrove armonico, misurato. Un raccoglimento, un punto d’appoggio da cui muoversi per poter fare, per essere liberi; al contrario del precipitare in un abisso senza fondo o l’essere chiusi senza via d’uscita. Perché anche la libertà ha bisogno di un centro, di un perimetro, di una misura, di un nido sicuro da cui partire e a cui tornare. Un’esperienza d’infinito nel finito che mi ha fatto tornare in mente “L’infinito” del laicissimo Giacomo Leopardi. Il poeta, con la visuale limitata da una siepe, non si affaccia al di sopra di quella o l’oltrepassa, ma rimane seduto e da quella limitazione sboccia in lui uno stato di grazia, una sublime visione dell’infinito che confina con Dio, o in Lui sconfina: “… e il naufragar m’è dolce in questo mare”. Naturalmente, come aveva ripetuto Agostino, e detto prima Gesù, è nel nostro cuore, nella cripta che ognuno ha dentro di sé, che s’incontra Dio. I mistici e i Santi non hanno avuto bisogno di riferimenti esteriori. Ma molti di noi non riescono ad arrivarci, e ci è d’aiuto il camminare verso le pievi e la forma raccolta dell’abside, o la fuga di colonne della cripta romanica.